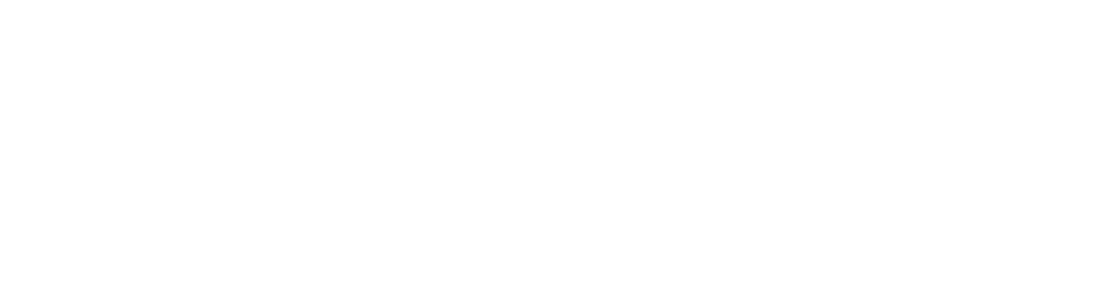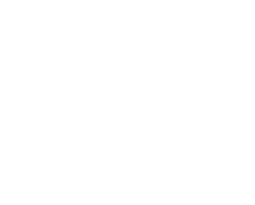ANSIA, DEPRESSIONE: LE CAUSE SONO GENETICHE?
I PROBLEMI PSICHICI SI POSSONO TRASMETTERE AI FIGLI?
Estraggo la frase che segue da un tipico articolo “scientifico” a proposito di un disturbo sessuale (ma potrebbe benissimo riguardare anche altri tipi di problemi: dai disturbi specifici dell’apprendimento, alle sindromi di iperattività, ecc.):
“Gli studi sulla familiarità dei disturbi hanno rilevato livelli di probabilità che variano tra il 40% e il 60% che il problema si manifesti tra consanguinei, quindi è possibile che la componente genetica rivesta un aspetto importante nella genesi del disturbo”. Segue quindi la presentazione della farmacoterapia indicata in base ai frutti della ricerca in questione.
Quante volte è capitato di leggere e dar credito a frasi di questo tipo? Continuamente.
Molto più spesso di quanto capiti di leggere prese di posizione critiche nei confronti di un approccio che, se da una parte pretende scientificità, dall’altra pare trascurare le premesse fondamentali della scienza stessa: chiarezza dei risultati e dei rapporti di causa tra la variabili prese in considerazione.
In pratica un’affermazione può dirsi scientificamente valida (tra le altre cose) se riesce a dimostrare che le correlazioni che ritiene esserci tra i dati non sono da attribuirsi a fattori diversi da quelli considerate: nell’esempio, il fatto che il ripresentarsi di un disturbo dentro una famiglia sia da imputarsi solo a fattori genetici.
In base a queste premesse appare piuttosto sconcertante che su uno stesso fenomeno possano essere considerate esaustive e chiare, ricerche dai risultati tanto opinabili non solo dal punto di vista numerico (un’incidenza “tra il 40% e il 60%” è accettabile?) ma anche dei nessi tra fattori diversi.
 Trovare una ricorsività di un determinato problema all’interno di una famiglia, soprattutto quando si parla di problematiche relative a funzioni strettamente correlate con la dimensione affettiva ed emotiva (alimentazione, sessualità, riposo, attivazione, ecc.), e spiegarla esclusivamente con un fattore genetico, appare quanto mai azzardato (per non dire improprio), come se tutto ciò che una famiglia trasmette ad un nuovo nato sia il solo patrimonio genetico.
Trovare una ricorsività di un determinato problema all’interno di una famiglia, soprattutto quando si parla di problematiche relative a funzioni strettamente correlate con la dimensione affettiva ed emotiva (alimentazione, sessualità, riposo, attivazione, ecc.), e spiegarla esclusivamente con un fattore genetico, appare quanto mai azzardato (per non dire improprio), come se tutto ciò che una famiglia trasmette ad un nuovo nato sia il solo patrimonio genetico.
Parlare di familiarità di un problema in termini esclusivamente genetici significa trascurare tutto quell’ampio spettro di modalità con cui una famiglia insegna al bambino ad affrontare un problema, esprimere un disagio, gestire un malessere e che possono determinare il fatto che questo bambini arrivi a sperimentare lo stesso tipo di problema senza che la genetica centri assolutamente nulla.
L’esempio tipico è il modo in cui in una famiglia si insegna a rispondere alle frustrazioni: se si tende, tanto per semplificare, a lasciare che il bambino impari a smettere di piangere da solo, questo imparerà a controllare le emozioni (e quindi ad accumulare stress) dentro di sé, mentre nel caso opposto (cioè se al bambino viene insegnato ad attendersi sempre l’aiuto dell’altro) lo stress sarà riversato nella relazione. L’esito sarà che una famiglia nella quale la maggior parte dei membri sono ipertesi (o “affettivamente dipendenti”, nel caso opposto) genererà un altro individuo iperteso senza che la genetica abbia fatto nulla.
Quali sono le conseguenze principali di questa “dimenticanza”?
In primo luogo evidenziando un’unica causa all’origine di un problema viene orientata la scelta terapeutica in modo univoco, stabilendo quale sia il trattamento più utile indicato, trattamento che in questi casi corrisponde quasi regolarmente ad un’indicazione farmacologica (ovvia conseguenza di un problema indicato come esclusivamente biologico).
In seconda battuta, si influenza la percezione che la persona ha di ciò che può fare rispetto al suo problema: cioè, nulla! Se la genetica ha decretato che è un gene difettoso a porci nella categoria dei malati, non ci sarà nulla che potrà cambiare questo aspetto, che potrà al massimo essere compensato, attutito, controllato o nascosto ma non risolto. Se è vero che, con uno sguardo miope, questa risosta può essere anche tranquillizzante (“è inutile che mi sbatta più di tanto o che mi faccia problemi, basta un po’ di farmaco e il problema si risolve”), non ci vuole molto per capire che in questo modo non si fa altro che sedersi sul problema stesso, invece che risolverlo.
Dalle considerazioni precedenti ne deriva una terza: l’adesione della persona a protocolli terapeutici all-life-long, cioè durevoli tutta la vita, senza possibilità di uscita.
La persona è rotta e al massimo si può provare a tenerla assieme in qualche modo.
Inutile dire che dietro ad una visione di questo tipo sussistano interessi economici corposi, come viene rilevato con sempre maggiore insistenza da ricerche e statistiche (con risultati meno vaghi degli esperimenti sopra citati) che riconoscono negli ultimi anni un’impennata della spesa farmaceutica delle famiglie italiane per ansiolitici, antidepressivi e stabilizzanti dell’umore, proprio nel momento in cui, anche nell’ambito scientifico, emergono sempre maggiori perplessità anche rispetto all’utilità dei farmaci nel trattamento di quello che si credeva essere il disturbo psichiatrico “da farmaco” per definizione: la depressione.
Il discorso che si pone non è ovviamente quello di dover arrivare a scegliere un trattamento buono contro uno cattivo, quanto piuttosto la necessità di mantenere un’ottica vigile sulle problematiche sperimentate, alla ricerca di un cambiamento qualitativamente diverso, che permetta una messa in gioco personale per raggiungere una qualità di vita soddisfacente.
Per dirla con J.Haley: “il modo in cui guarderai ad un problema determinerà il modo con cui cercherai di risolverlo, e la possibilità che avrai di riuscire a farlo”.
Dott.Carlo Boracchi