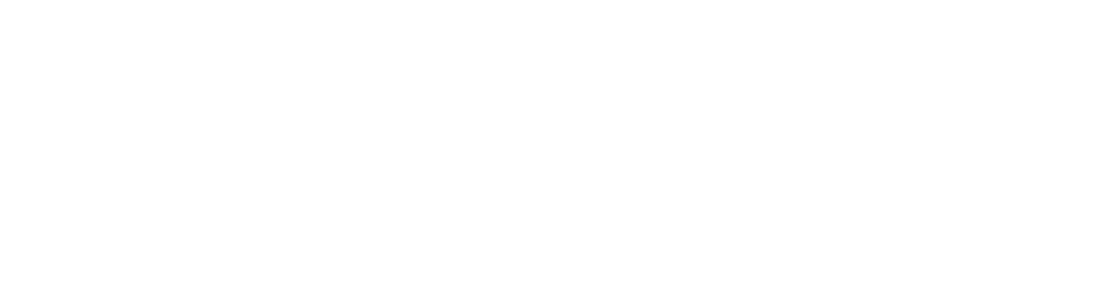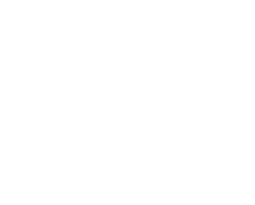STORIE DI PI
Come un film può spiegare l’elaborazione del dolore
<<Oggi le ho raccontato due storie. […]
In entrambe la nave affonda, in entrambe la mia famiglia muore e in entrambe ho sofferto molto.
Però lei quale preferisce??>>
Nel momento in cui ho sentito porre questa domanda mi sono sentito toccato sul vivo, come se l’interrogativo fosse rivolto davvero a me, come se in qualche modo urgesse una risposta da parte mia, se non a chi aveva domandato, almeno a me stesso.
Faccio un passo indietro.
Le parole che tanto mi hanno colpito non mi sono state dette da un paziente, ma dal protagonista del film “Vita di Pi”, Pi, appunto, giunto alla fine dell’emozionante racconto della sua vicenda.
Comprenderne il senso e la profondità risulta difficile per chi non ha avuto modo di seguirne la vicenda, che provo quindi di riassumere per sommi capi, cercando di non svelare troppi aspetti di una storia che merita di essere assaporata in tutta la sua bellezza.
Piscine (questo lo sfortunato nome del protagonista del film che, per scappare al tormento di un nome troppo storpiabile, decide di ribattezzarsi semplicemente Pi), è un bambino indiano dotato di una particolare sensibilità ed intelligenza, capace tanto di imparare a memoria centinaia di cifre decimali del Pi greco, quanto di interrogarsi sulle questioni più profonde dell’uomo e della sua ricerca di rapporto con Dio. La sua infanzia si svolge nel grande giardno zoologico di proprietà del padre, il cui “pezzo forte” risulta essere la nobile e maestosa Richard Parker, una tigre del bengala che affascina e intimorisce il giovane Pi.
Le vicissitudini esistenziali si snodano tra successi e crisi, giochi e amori, finchè le difficoltà economiche convincono il padre di Pi a cercare fortuna in Canada, portando con sé famiglia ed animali dello zoo nella traversata oceanica. Tutti i piani vengono tuttavia bruscamente distrutti da una violenta tempesta, che affonda la nave nel cuore dell’oceano, costringendo Pi ad un rocambolesco naufragio su una scialuppa di salvataggio sulla quale cercano un disperato rifugio anche Richard Parker (la tigre), una iena, un orango e una zebra.
Il viaggio che segue, narrato da un Piscine cresciuto e che quindi sappiamo sin dall’inizio del film scampato alla tragedia, è la storia poetica e drammatica di come, morti tre dei quattro animali sulla barca, Piscine impari a convivere con la tigre, a domarla, conoscerla, rispettarla e comprenderla.
Ma proprio quando il viaggio giunge all’agognata salvezza, incalzato da due scettici ispettori di una compagnia assicuratrice, che stentano a credere alla storia del naufragio con gli animali, Pi racconta un’altra storia, nella quale la poesia lascia il posto alla brutalità disarmante di una lotta per la sopravvienza nella quale quattro uomini naufraghi si sono uccisi a vicenda per sopravvivere, ultimo dei quali è rimasto il solo Piscine.
Queste sono le due storie di Pi e qui cade la domanda iniziale, posta da un Piscine sopravvissuto e cresciuto, ad un narratore in cerca di storie da raccontare: come dicevo una domanda stringente e diretta, e che mi sembra porre una questione fondamentale per chi abbia a che fare con storie tormentose, sia perchè terapeuta, sia perchè vissute in prima persona.
Il tema della ri-narrazione della propria vicenda esistenziale era già stato narrato almeno in altri due film molto appassionanti, “Big Fish – Le Storie di una Vita Incredibile” e “Train de Vie”, i quali mi paiono tuttavia intenderla in modo totalmente diverso. Un modo che spesso capita di incontrare nella nostra esperienza.
Nel film di Tim Burton, ad esemio, la rielaborazione della propria storia appare come un gioco di fantasia, un diletto per rendere speciale una vita probabilmente ordinaria, quasi un esercizio creativo che aggiunga alla quotidianità un brio speciale, un’eccezionalità che, certamente preziosa, risulta tuttavia capace solo di distrarre dai drammi che la vita può portare con sé, di fronte ai quali possiamo armarci di fantasia e immaginare altro, senza però affrontarli.
È la soluzione adottata quando si crede di non poter sostanzialmente cambiare le cose, o quando non ci interessa realmente provare a farlo: ciò che otteniamo è semplicemente dare una luce più brillante ma artificiosa alle vicende, che possono tuttavia progressivamente finire per allontanarsi dalla realtà, risultando inaccettabili per chi, vicino a noi, non è disposto ad accettare favole belle.
È questa la divergenza che divide padre e figlio all’inizio di “The Big Fish”, appunto: il figlio che chiede di conoscere la verità su una storia che è anche sua, e che conosce solo nelle irrealistiche epopee narrategli dal padre, per indorare una vita banale.
Simile per certi versi la drammatica storia degli ebrei in fuga dallo sterminio raccontata con maestria da Radu Mihàileanu, in un film nel quale la vicenda narrata si svela essere una pura illusione del protagonista, un sogno che nulla ha del confronto con una realtà probabilmente percepita come impossibile da elaborare, da affrontare, nella quale l’unica libertà possibile è il sogno. In tal caso l’illusione appare certamente più umana, comprensibile (chi, infatti, potrebbe mai accettare l’orrore e la disperazione dell’olocausto?), ma sostanzialmente identica.
Ogni illusione, prima o poi, finisce, e quanto più questa ci ha portato lontano dalla realtà, tanto più diventa duro riaffrontarla.
“Vita di Pi” mi pare invece affrontare il problema da un punto di vista diverso, molto vicino a quella che credo possa essere la risposta possibile, in un percorso terapeutico, a chi chiede un aiuto per affrontare un profondo dolore personale.
La storia narrata è quella di un ragazzo che deve necessariamente affrontare i propri demoni interiori, sopravvivere ad un’esperienza della quale non può evitare di affrontare gli esiti che costituiscono il suo presente, e questo è quello che fa.
Credo che il film rappresenti con efficacia la questione centrale che tormenta chi giunge ad intraprendere un percorso psicologico: trovare una nuova possibilità di raccontare la propria storia, comprendere il significato che porta con sé, dandosi la possibilità di sopravvivere ai suoi aspetti più critici o dolorosi.
C’è una possibilità di rileggere la nostra esperienza senza negarla, trasformarla, dimenticarla?
Ha un senso trovare un modo diverso di raccontare il nostro passato, restandovi al contempo fedeli?
A tali domande mi sembra che il film offra una risposta non banale, mostrando come la rilettura con altri occhi della nostra storia ci permetta di ricomprendere senza stravolgere ciò che è accaduto. Possiamo così scoprire, sentire e comprendere la tigre che c’è dentro di noi da sempre o che, scaturita da un dramma toccatoci in sorte, ci porta a fare i conti con sentimenti ancestrali, apparentemente incontrollabili, con i quali diventa difficile scendere a patti.
La metafora che costruisce il racconto, non cela la realtà, ma ne riconosce un valore ed un senso diverso, per comprendere il quale può essere necessario lasciar sedimentare il sentore più vivido dell’esperienza, il vissuto più crudo.
Il potere del racconto è il potere del linguaggio, grazie al quale è possibile toccare l’intoccabile, rendendolo più avvicinabile e comprensibile, accettabile.
E il mondo del linguaggio, della parola, è il mondo della psicoterapia, nel quale possiamo scoprirci capaci di camminare fianco a fianco con la tigre.
Dott. Carlo Boracchi
Ps: L’articolo prende spunto dal film Vita di Pi senza pretendere di esserne una lettura critica. Il film ha proprie tematiche, trame narrative e chiavi di lettura che esulano dalla questione psicoterapeutica. Semplicemente la sua visione mi ha sollecitato la riflessione che ho condiviso in questo articolo.